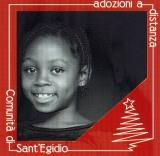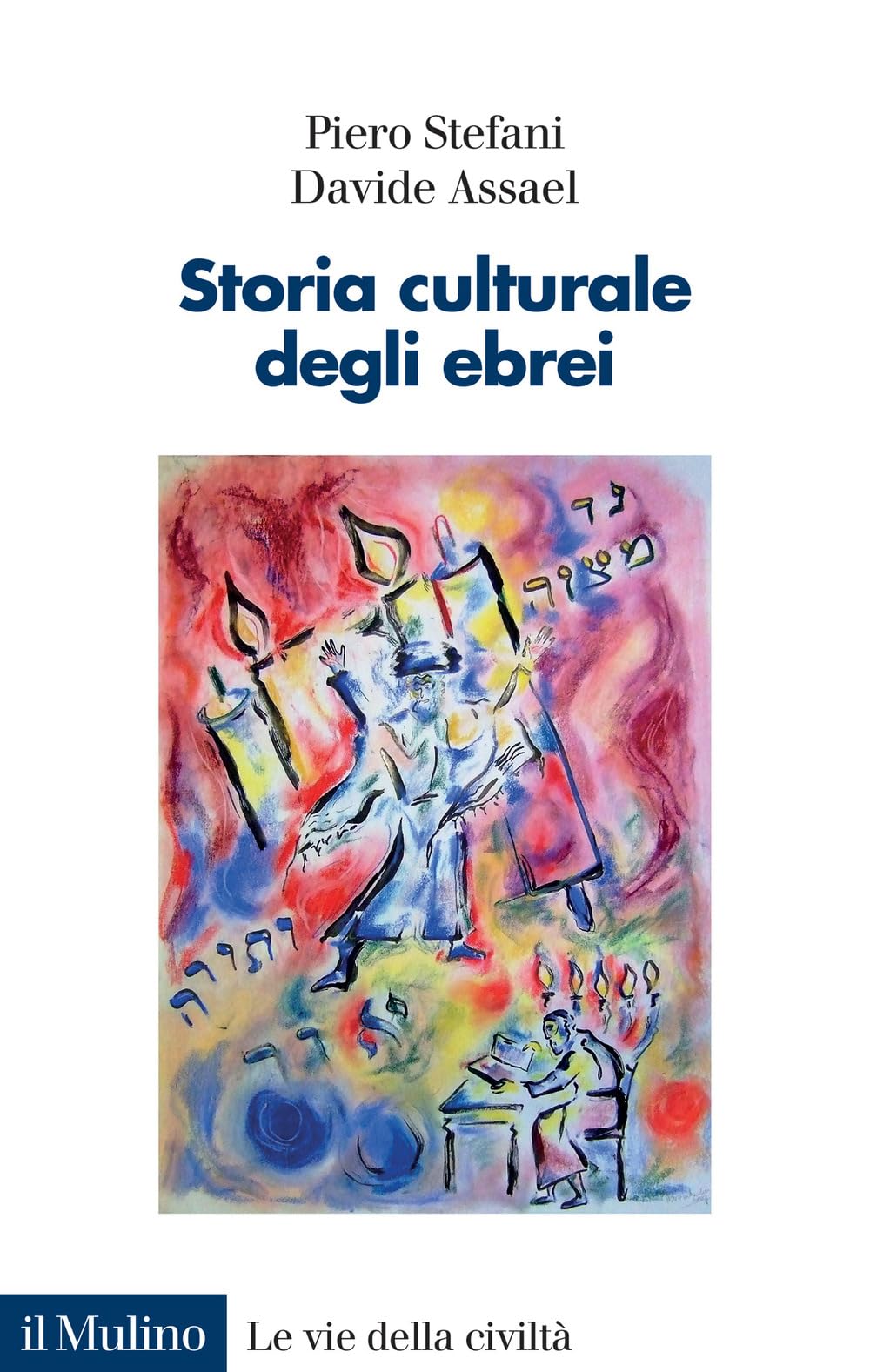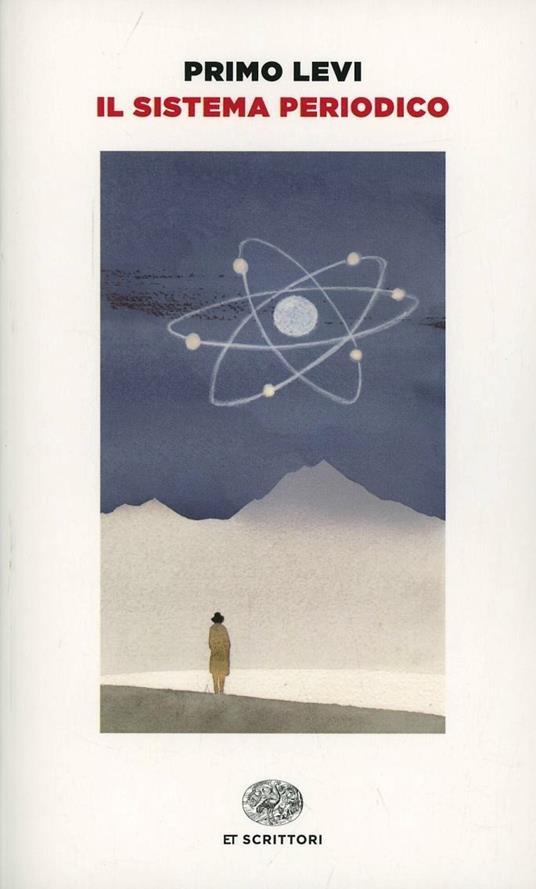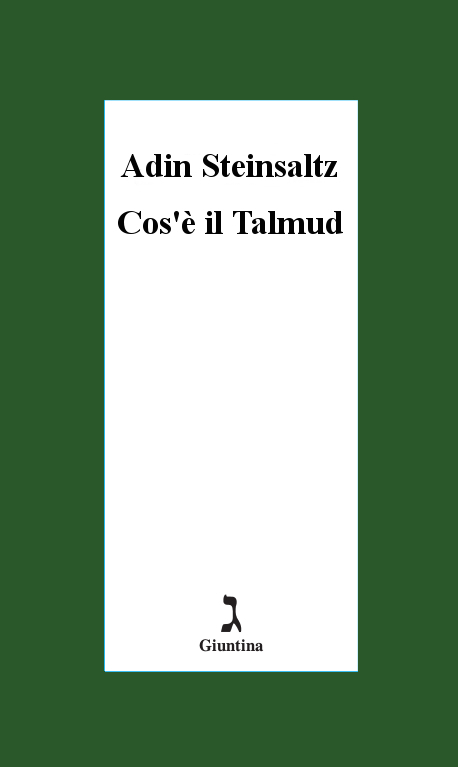(Chiesa Evangelica Valdese di Catanzaro, domenica 31 dicembre 2023)
Ecclesiaste 3,1-15
Care sorelle, cari fratelli,
che mistero il libro dell’Ecclesiaste, o del Qohelet!
La presenza all’interno del canone ebraico e cristiano di questo libro provoca davvero interrogativi enormi. Ma, d’altro canto, i testi delle nostre Scritture generano sempre, ed a ogni lettura, domande sempre nuove alle quali come credenti siamo invitati a rispondere interrogandoci a nostra volta.
Non dobbiamo scandalizzarci se non sempre riusciamo a comprendere sino in fondo il senso di ciò che leggiamo, l’importante è sempre e comunque porsi alla ricerca, non abbandonare il cammino, con l’assoluta e umile fiducia che il Signore saprà guidare i nostri passi sulla via del discernimento che, in ogni caso, sarà sempre parziale.
L’Ecclesiaste è proprio uno di quei libri problematici che sembra sfuggirti sempre dalle mani, ma forse proprio questa è la sua bellezza.
La sua ingestibilità ci consiglia di maneggiarlo con molta cura senza pervenire a soluzioni preconfezionate.
Rientra nel novero dei libri sapienziali, ma opera un netto distacco dallo stile e dal linguaggio della sapienza dei Proverbi, del Cantico dei Cantici, di Giobbe.
Forse proprio per questo ha destato e desta un immenso fascino, che ha indotto innumerevoli studiosi, teologi, scrittori, anche non credenti, ad interessarsi di questo libro, a provare a capire qual è esattamente il suo posto all’interno della Bibbia Ebraica, ma soprattutto cosa intende dire a chi lo legge.
Scetticismo, pessimismo, disperazione, addirittura cinismo: sono questi i caratteri che molti autori hanno attribuito all’Ecclesiaste. Addirittura alcuni ne mettono in evidenza l’assenza di Dio, nel senso che Dio c’è nel testo ma è un Dio distante, imperturbabile, un Dio che non agisce nella storia degli uomini.
E’ davvero così?
Certo ad una lettura disincantata del testo, saremmo portati a dare ragione a coloro che la pensano così. In effetti, in alcuni passaggi emerge la tentazione di condividerne anche la lettura pessimistica e disperante, lasciandosi andare ad una visione nichilista del senso delle parole dell’autore, che però sa fare anche un buon uso dell’ironia.
L’Ecclesiaste è peraltro un libro pieno di contraddizioni.
Anche per questo non è entrato nel canone biblico tanto agevolmente, ma oggi il suo testo è uno dei “Meghillot”, uno dei cinque rotoli che vengono letti pubblicamente durante alcune feste ebraiche. L’Ecclesiaste viene letto durante la festa della “Capanne” o “Sukkot” che ricorda la permanenza del popolo ebraico nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto.
Quindi l’Eccesiaste è un libro che “contamina le mani” come ogni altro libro della Bibbia Ebraica.
Come tale dobbiamo assumerlo e provare, dico solo provare, ad individuarne qualcuno tra i possibili sensi.
Ma chi ne è l’autore?
Egli si presenta, al capitolo 1, versetto 1, come “figlio di Davide, re di Gerusalemme”.
Quindi, saremmo portati ad intendere che si tratta del re Salomone. Un affascinante commento midrashico dice che Salomone avrebbe scritto da giovane il Cantico dei cantici, da uomo maturo il libro dei Proverbi e, nella sua disincantata vecchiaia, proprio il libro del Qohelet.
Ma tutti gli studi più approfonditi sono d’accordo nell’attribuire il testo ad un aristocratico “predicatore”, ad un “raccoglitore” vissuto tra il II° e il III° secolo a.C., in piena epoca ellenistica.
In effetti, Ecclesiaste significa proprio “predicatore” e Qohelet deriva dalla parola ebraica “Qol” che significa voce.
L’Ecclesiaste è proprio una predica, la voce di un predicatore rivolta all’Assemblea.
Prima di passare al nostro testo di questa domenica, è però interessante tracciare, in un rapido quadro, i temi che l’autore affronta nel suo scritto.
Tutto libro è pervaso dalla riflessione sulla “vanità”. Esordisce al capitolo 1, versetto 2, con “vanità delle vanità, tutto è vanità”.
Il senso del vivere è racchiuso all’interno dell’assoluta vanità delle azioni umane, ma la vita, se vuole sconfiggere questa vanità deve sempre volgersi al timore di Dio.
Entrando nel merito del nostro testo, possiamo suddividerlo in due parti: la prima dai versetti dall' 1 all’ 8 e poi i versetti dal 9 al 15.
La prima parte è un vero e proprio poema che si può leggere in parallelo a quello del capitolo 1 dal versetto 2 all’11:
“2 Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità.
3 Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? 4 Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. 5 Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. 6 Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione; va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. 7 Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie; al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. 8 Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire; l'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. 9 Ciò che è stato è quel che sarà; ciò che si è fatto è quel che si farà; non c'è nulla di nuovo sotto il sole. 10 C'è forse qualcosa di cui si possa dire: «Guarda, questo è nuovo?» Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. 11 Non rimane memoria delle cose d'altri tempi; così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi.”
In questi versetti del 1° capitolo l’Ecclesiaste ci pone di fronte all’immutabilità della creazione. Tutto, nel disegno di Dio, è funzionale alla sussistenza della terra. Tutti gli elementi hanno il loro ciclo vitale per assicurare la vita del pianeta.
Si generano e si rigenerano, in un moto circolare continuo che non conosce sosta e che è indipendente da qualsiasi volontà umana.
Certo oggi potremmo dire che l’uomo è arrivato ad un livello così alto, e talvolta distruttivo, di conoscenze scientifiche e tecnologiche che è anche in grado di condizionare pesantemente il ciclo vitale degli elementi.
Il riscaldamento globale è infatti una delle più grandi preoccupazione dei cittadini e delle cittadine.
Ma, l’Ecclesiaste ci mette in guardia: l’uomo pensa di essere il padrone dell’universo, ma anche questa presunzione, potremmo dire, è vanità della vanità.
Al di sopra dell’uomo c’è la sovranità di Dio che governa l’alternarsi degli elementi, il ciclo della vita della Terra.
L’uomo non riuscirà mai ad arrogarsi il diritto di alterare la creazione buona di Dio, perchè in questa creazione c’è un ordine immodificabile che non è a disposizione dell’uomo.
L’uomo potrà continuare ad inquinare, a fare guerre, a distruggere l’ambiente che lo circonda, ma la creazione di Dio è inscalfibile.
Questa creazione resisterà anche alla malvagità dell’uomo, alla mancanza di cura per i suoi simili, al suo egoismo.
La storia del diluvio ce l’ho insegna: “..Io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuor dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza; e non colpirò più ogni cosa vivente, come ho fatto. 22 Finché la terra durerà, sementa e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai” (Genesi 8,21-22).
Confrontando i due poemi del capitolo 1 con il nostro del capitolo 3, è evidente che l’Ecclesiaste pone un distacco tra ciò che è governato da Dio e ciò che può essere gestito dalle mani dell’uomo.
Nel versetti di questa domenica, c’è il nostro spazio, lo spazio delle nostre vite, delle nostre scelte.
Ed è significativo che la nostra liturgia ci propone questo testo a conclusione dell’anno e in prospettiva all’anno nuovo.